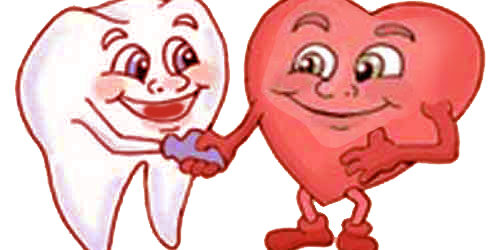Quando parliamo di endocardite, parliamo di un’infiammazione che colpisce l’endocardio, la membrana che riveste internamente le pareti del cuore, nonché tutte le formazioni presenti nelle cavità cardiache stesse (valvole, muscoli papillari, corde tendinee,..)
Tale condizione può essere ad insorgenza non-infettiva e infettiva; poiché quest’ultima si ha nella maggior parte dei casi è quella su cui ci soffermeremo nell’articolo.
L’endocardite infettiva è comunemente dovuta ai batteri ma anche altri agenti patogeni possono determinare il processo flogistico.
Venne descritta per la prima volta nel 1885 dal patologo canadese William Osler che la definì come “malignant endocarditis”, proprio perché allora, rispetto ai giorni nostri, era molto più difficile da diagnosticare e da trattare.
Ad oggi l’incidenza di tale condizione è decisamente più bassa: 3-5 casi su 100.000, ma assolutamente da non sottovalutare.
L’infiammazione dell’endocardio si verifica quando microrganismi, provenienti da altri distretti corporei come intestino, cute, cavo orale,.. entrano in circolo e, attraverso il sangue, raggiungono il cuore.
I principali responsabili sono:
– streptococchi
– stafilococchi
– candida e batteri del gruppo HACEK (in percentuali minori)
Normalmente il nostro sistema immunitario riconosce e contrasta la diffusione di questi agenti patogeni, rendendoli innocui e proteggendo così l’organismo, anche se dovessero arrivare al cuore.
Il problema insorge quando le strutture cardiache sono danneggiate magari per patologie cardiache congenite, episodi di febbre reumatiche o altre condizioni acquisite. Riportiamo in Tabella 1 i principali soggetti a rischio.
I microrganismi inducono un danno iniziale dei tessuti, che attiva la cascata infiammatoria inducendo il rilascio di citochine e mediatori dell’infiammazione, i quali a loro volta favoriscono la produzione di fibronectina, una proteina presente sulle membrane cellulari, coinvolta nella formazione di un coagulo, coagulo su cui avverrà l’adesione batterica (colonizzazione) e a cui seguiranno un incremento del danno endoteliale e la formazione di vere e proprie vegetazioni.
L’endocardite è una condizione assolutamente da non sottovalutare,
perché ancora potenzialmente letale, ma molto importante è il fatto che può essere PREVENUTA, attraverso una profilassi antibiotica peri-operatoria raccomandata in quei pazienti a rischio elevato descritti sopra.
In presenza di cardiopatia a rischio, quali procedure odontoiatriche la richiedono?
– Estrazioni di denti o radici (es. ottavi inclusi)
– Chirurgia parodontale
– Interventi che coivolgono il tessuto osseo (es. implantologia)
– Trattamento di infezioni pulpari o quando si opera in siti infetti o in pazienti con scarsa igiene orale
– Procedure in cui si manipolano i tessuti muco-gengivali note per causare sanguinamento (es. ablazione del tartaro)
Ma un ruolo importante lo gioca anche il paziente! Perché?
Perché è il paziente stesso che, nel suo piccolo, deve contribuire alla riduzione dell’infiammazione e del processo infettivo! Migliorando la propria igiene orale o continuando a mantenerla in uno stato ottimale e facendo sciacqui con colluttori a base clorexidina si riduce l’entità dei batteri che possono andare in circolo.